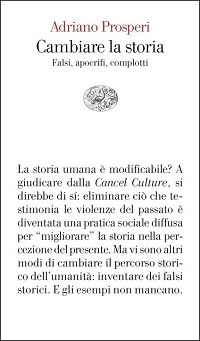
Il volumetto di Adriano Prosperi presenta le vicende di alcuni dei più noti casi di falso storico ed è una lettura utile ad una comprensione critica della narrazione storica e alla confutazione della propaganda; l'apparato bibliografico enumera altri saggi analoghi e un gran numero di monografie oltremodo utili per indagini più accurate.
Prosperi sottolinea nella prefazione come l'idea che lo storico abbia un vincolo esclusivo nei confronti della verità si sarebbe affermata non prima della fine del XVII secolo, senza che questo sottraesse comunque essa verità ad attacchi più o meno insidiosi, dato che l'irrimediabilità degli accadimenti storici, a meno di tagli e correzioni, avrebbe sempre riservato "pagine amare, sconfitte politiche, vicende ignobili, scelte vergognose della propria cultura o della patria di appartenenza". Marc Bloch viene citato da Prosperi come eminente ed esplicito difensore della verità storica; le Riflessioni di uno storico sulle false notizie della guerra in cui confutava le dicerie sulle nefandezze tedesche avrebbe presentato già la tendenza che avrebbe caratterizzato I re tamuaturghi, ricerca su una "gigantesca falsa notizia" medievale che aveva fatto sentire i suoi effetti fino al XIX secolo. Il mestiere di storico, riassume l'A. citando Carlo Ginzburg, dovrebbe consistere nel "districare l'intreccio di vero, di falso e di finto che è la trama del nostro stare al mondo". Nonostante questo, la verità storica soffrirebbe oggi degli attacchi di due diverse tendenze. La prima risentirebbe delle condizioni di un presente poco rassicurante, che spingerebbero anche chi si dedica "all'umbratile mestiere di studiare il passato" a prendere "la veste del profeta". La seconda sarebbe dovuta al processo a "un passato storico di conquiste coloniali e di sopraffazioni che appare così immorale e intollerabile da meritare la cancellazione", attualmente in atto in tutte le società occidentali. L'estremo della cancel culture sarebbe rappresentato dal tentativo di operare cambiamenti simbolici cancellando le tracce di un passato percepito come vergognoso, cominciando dai monumenti pubblici. La tendenza a manipolare un passato percepito come intollerabile sarebbe comunque antichissima, e assecondata adendo la via del falso; per quanto validi possano essere i progressi della critica testuale, le innumerevoli falsificazioni del passato produrrebbero risonanze persistenti nella sua percezione; per questo l'A. considera importante riesaminare alcuni casi fra i più celebri alla luce dei risultati delle ricerche esistenti.
Prosperi inizia trattando della Donazione di Costantino imperatore a papa Silvestro, un documento che presenta tutti i caratteri di un vero diploma mentre riguarda un episodio mai accaduto e sui cui protagonisti le fonti storiche dicono l'opposto, ricordando il battesimo di Costantino ad opera di un vescovo ariano e facendo di Silvestro un traditor che sotto Diocleziano avrebbe consegnato alle autorità imperiali libri e oggetti sacri. Prosperi ripercorre il lavoro di ricostruzione delle circostanze che avrebbero permesso la fabbricazione del falso -quelle dei rapporti tra Adriano I e Carlo Magno- e quello di identificazione del luogo, con ogni probabilità la curia papale. Prosperi considera la portata delle conseguenze derivanti dal Constitutum Constantini e ne rileva l'eco anche nelle vicende dell'epoca contemporanea, prima di ripercorrere la ricorrente questione della sua legittimità, messa più volte in discussione con buone ragioni dal potere imperiale -ma anche da figure come l'Alighieri, che ne rilevavano le storture e le gravi conseguenze che avevano avuto sull'assetto ordinato della società cristiana- e altrettante volte ribadita dal soglio pontificio. Sarebbe stato Lorenzo Valla nel 1440 a provare la falsità del Constitutum ricorrendo ai mezzi della filologia e della storia -e per la causa della verità e della giustizia- in uno scritto dai toni veementi e appassionati quali li avrebbe usati un cristiano offeso dalla degenerazione morale del papato. Prosperi ricorda anche la scarsa fortuna che Valla ebbe nell'immediato, e la cortina di silenzio cui si sarebbero prestati i letterati dell'umanesimo ciceroniano gravitanti attorno alla corte romana e ai benefici ecclesiastici. Sarebbero state la stampa e la riforma protestante a rovesciare le sorti dello scritto del Valla: la lettura di Valla sarebbe stata fondamentale per Lutero e per la sua concezione del rapporto tra potere spirituale e potere secolare, cosa che sarebbe valsa all'opera del filologo autentici attacchi frontali da parte cattolica. Ma ancora nel XVII secolo il Constitutum avrebbe trovato nella società quel "terreno di coltura favorevole" che Marc Bloch considerò fondamentale per l'affermazione del falso.
Prosperi ricorda come il lascito di Lorenzo Valla -morto nel 1457- sarebbe stato raccolto da molti intellettuali. Con la stampa a caratteri mobili il consumo crescente di storie avrebbe visto diffondersi non solo le traduzioni, ma anche "letture che rispondevano all’ansia di conoscere qualcosa sulle remote regioni che restavano al di là della portata umana: le sterminate antichità antediluviane e il tempo dell’apocalisse", che era competenza di autori di pronostici e almanacchi che si fondavano per lo più sullo studio delle congiunzioni astrali. Il religioso domenicano Giovanni Nanni, firmandosi Annius Viterbiensis, avrebbe iniziato a interessarsi proprio di profezie e di astrologia per poi elaborare -aiutato da una considerevole erudizione- una per lo meno fantasiosa storia di Viterbo, sua città di origine. Annius avrebbe falsificato materiali epigrafici, influenzato artisti, blandito potenti e redatto decine di volumi di testi inventati ma ascritti ad autori remotissimi per attribuire a Viterbo origini tanto nobili quanto lontane nel tempo. L'opera di coordinazione sistematica di iscrizioni false, testi pseudonimi e commentari fantasiosi avrebbe fatto di Annius l'inventore della falsificazione scientifica e avrebbe comunque assicurato un vasto e diffuso successo ai suoi scritti: un reale bisogno di conoscenza del passato remoto soprattutto nei piccoli Stati della penisola. Prosperi sottolinea come il successo delle "antiquitates" di Annio avrebbe inquinato per almeno duecento anni la storiografia sul mondo antico di buona parte d'Europa, nonostante le smentite e le sbugiardature subite fin dai primi anni del XVI secolo. Giovanni Nanni e le sue genealogie postdiluviane avrebbero influenzato anche il dibattito sugli abitanti del Nuovo Mondo e sul loro diritto o meno di essere considerati esseri umani a pieno titolo, agevolando la costruzione di una vera e propria paraetnografia.
Prosperi ricorda come il Constitutum avrebbe resistito come manoscritto attribuito a Costantino per diversi secoli, prima di essere confutato da Lorenzo Valla con gli strumenti dellla filologia. L'archeologia sarebbe invece servita per sotterrare e far riscoprire reperti misteriosi ad Annio Viterbese, che in questo avrebbe trovato molti imitatori. Il terzo capitolo ripercorre la vicenda dei falsi del Sacromonte di Granada, svoltasi alla fine del XVI secolo. In questo caso una serie di oggetti manipolati sarebbe servita a cercare di risollevare la condizione dei moriscos, redimendoli con la costruzione di un passato mitico in un momento storico e in un contesto sociale in cui la limpieza de sangre era un discrimine estremamente difficile da superare. L'A. scrive che gli autori della falsificazione sarebbero stati individuati con buona certezza proprio in esponenti della società morisca; a fronte dell'avanzare della repressione avrebbero pensato di costruire una Granada di mori cristiani risalente alla prima predicazione evangelica e caratterizzato dalla devozione all'Immacolata, prevedendovi un San Cecilio protovescovo moro e un'eredità di profezie che avrebbero anticipato eventi storici del XVI secolo. L'attivismo dei vescovi di Granada avrebbe fatto sì che i falsi venissero fatti propri dal cattolicesimo spagnolo, che se ne sarebbe servito nel contesto delle proprie dispute teologiche nonostante le aspre polemiche con Roma sulla questione dell'autenticità. Prosperi nota una eloquente correlazione tra gli argomenti maggiormente dibattuti e le conferme fornite dalle "scoperte" di testi e documenti sul Sacromonte; il loro presentare il cattolicesimo spagnolo come antichissimo e senza macchia avrebbe paradossalmente alimentato la chiusura e l'ostilità verso gli stessi moriscos -culminata nella loro espulsione dalla penisola iberica iniziata nel 1609- e avrebbe alimentato all'inizio del XVII secolo l'immacolatismo sivigliano, un fenomeno che avrebbe portato a una vera fanatizzazione delle masse popolari e la cui causa sarebbe stata fatta propria dai gesuiti. Il movimento a favore della ratifica dogmatica dell'Immacolata Concezione sarebbe arrivato ai vertici della società spagnola, che se ne sarebbero serviti per rafforzare la coesione del Regno e per esercitare una serie di pressioni sulla curia romana. Nel 1682 Roma avrebbe condannato gli scritti del Sacromonte ma non gli altri reperti; un compromesso con cui Roma avrebbe esaltato l'antichità del cristianesimo andaluso cancellando invece le tracce moresche. A differenza del Constitutum e del lavoro di Giovanni Nanni, nota Prosperi, ai falsi del Sacromonte sarebbe mancato del tutto quel "terreno di coltura favorevole" che secondo Marc Bloch sarebbe condizione necessaria al successo di operazioni del genere.
L'ultimo capitolo del saggio tratta di un caso di falso che non solo ha retto alle confutazioni, ma ha continuato a godere di una fortuna crescente anche grazie alla conclamata impermeabilità dei suoi fruitori a qualsiasi approccio critico. Prosperi ricorda gli effetti mortali dei Protocolli dei savi anziani di Sion, un libro che avrebbe ispirato pogrom fin dalla sua comparsa e che può essere considerato corresponsabile dello sterminio degli ebrei d'Europa. Ristampati, manipolati, tradotti in un numero di edizioni difficile da quantificare con precisione e diffusi nella penisola italiana da Giovanni Preziosi fin dal 1921, i Protocolli presenterebbero il programma di un'organizzazione segreta da sempre dedita ad attentare agli assetti sociali e politici esistenti per sostituirvi un potere ebraico. Il libro avrebbe alimentato per generazioni la convinzione che esista un'organizzazione di cospiratori dedita alla rovina del genere umano, e perpetuato superstizioni demonologiche sul conto dell'ebraismo nonostante ampie e circostanziate confutazioni. Nato come manoscritto in Francia, riordinato e stampato in Russia nel 1903 dal mistico e visionario Sergej Aleksandrovič Nilus che lo avrebbe ricevuto dalla polizia politica russa, il testo dei Protocolli avrebbe ampliato a dismisura la propria fortuna dopo il 1917 anche se sarebbe stato oggetto di confutazioni corcostanziate fin dal suo primo circolare. Sarebbe stato il corrispondente del Times a Istanbul Philip Graves a dimostrare nel 1921 la "dipendenza testuale" dei Protocolli da un pamphlet contro Napoleone III scritto nel 1864. Dopo l'uscita dell'edizione statunitense del 1920, scrive Prosperi, smentite e confutazioni si sarebbero rivelate inefficaci perché il falso dei Protocolli "rivelava qualcosa a cui si era pronti a credere perché lo si era sempre saputo". Anche se "falso" il libro sarebbe apparso "veridico", e a tirargli la volata sarebbe arrivato il prestigioso patrocinio dell'industriale dell'automobile Henry Ford. Secondo l'A. la predisposizione diffusa ad attribuire agli ebrei nefandezze inaudite si sarebbe riaffermata in coincidenza con l'emancipazione, con la sostituzione della tradizionale ostilità religiosa con quella razziale; l'elaborazione dei Protocolli sarebbe avvenuta proprio in questo clima, conferendo a un'ossessione antica una forma adeguata all'epoca contemporanea. L'A. ricorda a questo proposito come una "ossessione paranoide del complotto ebraico" radicata da secoli si fosse trasformata fino a diventare una propensione ad addossare agli ebrei la diffusione dei "mali della modernità", e ripercorre la nefasta fortuna dei Protocolli dalla Germania nazionalsocialista al mondo arabo contemporaneo, constatando ancora una volta come a tutt'oggi un testo falso al di là di ogni dubbio fornisca un ritratto dello stato del mondo che in troppi sarebbero propensi a riconoscere per vero, in un'ossessione per il complotto che prospera anche senza necessità di referenti reali.
Adriano Prosperi - Cambiare la storia. Falsi, apocrifi, complotti. Torino, Einaudi 2025. 160 pp.
Adriano Prosperi - Cambiare la storia. Falsi, apocrifi, complotti
- Visite: 24
