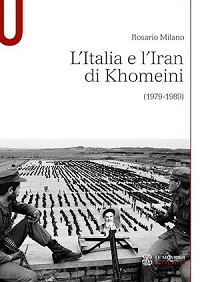
La monografia di Rosario Milano tratta dei rapporti tra lo stato che occupa la penisola italiana e la Repubblica Islamica dell'Iran nel periodo compreso fra il 1979 e il 1989. Il libro descrive relazioni diplomatiche e politiche attingendo per lo più a fonti primarie e a memoriali, e riporta con un certo dettaglio la natura, l'andamento e gli esiti dei rapporti intrattenuti a livello ufficiale dall'inizio della Rivoluzione fino alla scomparsa di Ruhullah Musavi Khomeini
La prefazione di Siavush Randjbar Daemi sottolinea come l'aver mantenuto sedi e rapporti diplomatici con Tehran anche nei periodi più burrascosi abbia consentito ai diplomatici inviati da Roma di essere testimoni della cacciata spesso violenta dell'opposizione iraniana dalla scena politica, della resistenza agli invasori iracheni nella Guerra Imposta e della transizione dall'ayatollah Khomeini ai suoi discepoli. Non colluso con i Pahlavi, lo stato che occupa la penisola italiana avrebbe avuto anche l'appoggio di diversi uomini influenti nella Repubblica Islamica e avrebbe continuato a contribuire senza soluzione di continuità allo sviluppo industriale del Paese nonostante l'esistenza di lobby filoirachene vicine al Partito Socialista grazie alla linea politica e diplomatica osservata soprattutto da Giulio Andreotti.
L'introduzione nota come l'accordo sottoscritto con Reza Pahlavi da Enrico Mattei nel 1957 fosse un esempio di "alleanza tra paesi sconfitti" da cui i contraenti avrebbero sperato di uscire rafforzati, anche se la successiva serie di accordi per la collaborazione commerciale, culturale e tecnica non avrebbe prodotto vantaggi sensibili per l'economia dello stato che occupa la penisola italiana. La morte di Mattei avrebbe prodotto una cesura nelle relazioni che Roma si sarebbe impegnata a superare soprattutto dall'inizio degli anni Settanta, un periodo in cui Roma avrebbe cercato di diversificare i propri fornitori di energia e in cui i Pahlavi avrebbero usato i proventi del petrolio per una conversione industriale di cui sarebbero in pochi anni emersi i limiti e le storture. Nel 1979 la comunità degli interessi che faceva capo a Roma avrebbe cercato immediatamente contatti con i rivoluzionari per garantire l'incolumità fisica e la salvaguardia degli investimenti effettuati in Iran. Secondo Milano l'atteggiamento pragmatico di Giulio Andreotti avrebbe reso la diplomazia di Roma il principale punto di riferimento della Repubblica Islamica in una Europa sostanzialmente ostile; e proprio l'archivio di Andreotti sarebbe stata una delle principali fonti documentali per la redazione del libro.
Milano apre il primo capitolo riassumendo gli avvenimenti del febbraio 1979, con la formazione dell'esecutivo provvisorio guidato da Mehdi Bazargan. Il nuovo governo sarebbe stato rapidamente riconosciuto da URSS, USA, paesi della allora CEE e Repubblica Araba di Siria; l'intento dell'esecutivo provvisorio sarebbe stato quello di reimpostare le relazioni con le grandi potenze, relazioni che non necessariamente avrebbero dovuto prendere forma conflittuale nonostante l'apertissimo antiamericanismo delle masse e le azioni dei combattenti irregolari dei Fedayyin e-Khalq. Lo stato che occupa la penisola italiana si sarebbe rapportato senza formalità con il nuovo governo, dal momento che la norma prevalente nel diritto e nelle consuetudini internazionali impone un riconoscimento vero e proprio solo in caso di nascita di un nuovo Stato. Il saggio descrive quindi i rapporti tra l'allora ambasciatore Giulio Tamagnini e le nuove autorità, interessate innanzitutto a regolare la presenza dei lavoratori stranieri, a far ripartire le esportazioni di idrocarburi e a lottare contro la disoccupazione. Il nuovo esecutivo avrebbe verificato caso per caso l'utilità e la fattibilità delle grandi opere programmate dallo Shah; pur con la sospensione dell'enorme cantiere portuale di Bandar Abbas (gravato da accuse di corruzione) e la fine del programma nucleare di Tricastin, le società facenti capo al Ministero delle Partecipazioni Statali dello stato che occupa la penisola italiana sarebbero rimaste presenti e operative, anche per l'esplicito apprezzamento espresso dall'esecutivo nei confronti di organizzazioni come l'ENI e del loro modo di comportarsi. Non sarebbero comunque mancati problemi per la riscossione dei vecchi pagamenti e vari casi di assalto ai cantieri da parte della forza lavoro di un Iran in cui per anni sarebbero avvenuti repentini avvicendamenti istituzionali e in cui i comitati rivoluzionari avrebbero operato per tutelare i diritti dei lavoratori rispetto alle società straniere. Milano precisa che alle attestazioni di stima ben note in ambiente diplomatico e commerciale avrebbero fatto seguito risultati concreti poco rilevanti.
Milano espone quindi le vicende dell'esecutivo Bazargan, affetto da una scarsa rappresentatività, dalle spinte centrifughe delle minoranze e ancor più dall'efficacia con cui la componente religiosa dello schieramento rivoluzionario avrebbe lavorato per la propria affermazione di concerto con i bazari e grazie ai fondi del Bonyad-e Mustad'afin. I religiosi avrebbero rapidamente costituito un governo ombra e monopolizzato i comitati e i tribunali rivoluzionari, procedendo con sanguinose epurazioni contro le minoranze e contro le stesse forze armate, contando infine sulle formazioni del Sepah-e Pasdaran-e Engelab-e Eslami istituito per decreto da Khomeini. Alle rimostranze della diplomazia occidentale Bazargan avrebbe risposto cinicamente, lasciando l'Occidente in difficoltà davanti alla realtà inedita e complessa rappresentata dall'Islam politico. Milano scrive che il "mito rivoluzionario" avrebbe "accecato" l'Occidente togliendo alle forze politiche e sociali la lucidità necessaria "a capire e individuare gli scenari realistici relativi all'evoluzione della politica iraniana sul piano domestico e degli affari esteri". Per quanto riguarda la sinistra politica nella penisola italiana il referendum favorevole all'instaurazione di una repubblica in cui il carattere islamico era dettato costituzionale, l'assetto statale derivatone -caratterizzato dalla dualità di istituzioni costrette a coabitare- e il pragmatismo con cui Khomeini avrebbe portato avanti la realizzazione del suo modello di Stato e di società avrebbero segnato la fine di qualsiasi idillio. L'occupazione dell'ambasciata statunitense del 4 novembre 1979 ad opera degli "Studenti che seguono la linea dell'Imam" avrebbe ricompattato in nome dell'antimperialismo il fronte interno contro l'esecutivo provvisorio, e segnato un taglio definitivo col passato relegando in esso anche i tentativi di Bazargan di conservare con gli USA relazioni tali da ottenerne gli armamenti necessari a reprimere le insurrezioni nelle province. Per i paesi occidentali la salvaguardia dei propri interessi economici e degli investimenti avrebbe avuto la precedenza sulla questione degli ostaggi, nonostante la situazione fosse quella di una grossa violazione del diritto internazionale. Gli USA avrebbero invece gradito che il processo di normalizzazione dei rapporti tra Iran e Paesi europei si interrompesse in qualche modo e che la situazione economica della Repubblica Islamica continuasse a peggiorare.
Milano ricorda le conseguenze della dottrina del velayat-i-fiqh, prevista dalla costituzione entrata in vigore il 3 dicembre 1979; alla imposizione di un quadro istituzionale inedito si sarebbe accompagnata una rottura definitiva tra clero quietista e clero rivoluzionario, che avrebbe avuto il sopravvento anche grazie all'invasione sovietica dell'Afghanistan. L'elezione a larghissimo suffragio a Presidente della Repubblica di Abolhassan Bani Sadr (molto popolare presso le classi meno abbienti per la sua politica da ministro delle finanze) avrebbe permesso a Khomeini di insediare una figura laica spendibile a livello internazionale e rappresentativa della volontà popolare. Per le successive elezioni parlamentari il Partito Rivoluzionario Islamico avrebbe accusato tutte le altre forze politiche di voler imporre modelli politici stranieri a imitazione dell'Occidente o dei paesi socialisti e sarebbe stato nettamente legittimato dagli elettori nelle elezioni politiche della primavera del 1980. L'A. ricorda anche come il fallito raid statunitense per liberare gli ostaggi e l'avvento dell'amministrazione Reagan avrebbero ristretto i margini delle iniziative diplomatiche dei paesi NATO, facendo diventare complementari agli interessi statunitensi anche le iniziative dello stato che occupa la penisola italiana. Nell'immediato però la presenza di imprese e cittadini costruttivamente operanti in territorio iraniano avrebbe aumentato a Roma la consapevolezza di una relativa vulnerabilità a eventuali ritorsioni da parte della Repubblica Islamica, mentre l'esistenza di una consolidata tradizione diplomatica avrebbe anche impedito -anche a Bruxelles- un pronto adeguamento alle perentorie richieste degli USA. Milano sottolinea esplicitamente il persistere degli ottimi rapporti esistenti tra imprese come la Agusta e la Repubblica Islamica; la visita del ministro degli esteri Ghotbzadeh a Roma nel febbraio 1980 avrebbe avuto anche lo scopo -non raggiunto per la perentoria intromissione statunitense- di invocare l'adempimento dei contratti già onorati da parte iraniana. Di contro, gli ambienti politici e diplomatici della penisola italiana avrebbero riposto considerevole fiducia nell'economista e intellettuale Bani Sadr, il cui vasto sostegno pareva una buona garanzia contro il dualismo che era costato il posto a Bazargan. Nonostante le esplicite esortazioni di Tamagnini per una soluzione alla crisi degli ostaggi, il colpo degli studenti fedeli alla linea dell'Immam sarebbe apparso come un colpo inaudito a una potenza imperialista e anche per questo Bani Sadr non sarebbe riuscito ad avere la meglio sull'intransigenza del clero e della base rivoluzionaria.
Milano ricorda come l'esplicito sostegno di Khomeini alla vasta e radicata ostilità ai Pahlavi e agli USA diffusa nell'opinione pubblica iraniana e il suo appoggio agli studenti avrebbe eliminato qualsiasi margine di manovra per gli ipotetici intermediari. I paesi della CEE non avrebbero seguito gli USA nella rottura dei rapporti diplomatici con Tehran e non avrebbero aderito al varo delle sanzioni più dure fino a dopo il fallito blitz statunitense del 24 aprile 1980, che avrebbe ulteriormente polarizzato le posizioni tanto in Iran quanto in USA. In ogni caso, dopo la vittoria del Partito Rivoluzionario Islamico alle elezioni politiche e mentre le università iraniane diventavano terreno di scontro fra attivisti di sinistra e sostenitori di Khomeini (cosa che portò poi alla chiusura degli atenei) una rappresentanza sindacale e politica peninsulare avrebbe partecpato a una conferenza internazionale sull'ingerenza straniera patrocinata tanto da Bani Sadr quanto da Khomeini. Il saggio precisa che la Repubblica Islamica dell'Iran avrebbe comunque aggirato le sanzioni rivolgendosi a paesi terzi o non allineati e che la diplomazia di Roma avrebbe cercato di proteggere gli interessi di imprese e cittadini prima che di ottemperare ai desideri (o meglio ordini) statunitensi.
Le sanzioni e i problemi irrisolti -la contrazione delle esportazioni, l'inflazione, la disoccupazione urbana- avrebbero indebolito molto la presidenza di Bani Sadr già nel giugno del 1980. Milano scrive che l'insediamento della nuova Majlis a maggioranza repubblicana islamica non avrebbe avallato la consegna degli ostaggi dagli studenti alle istituzioni che Bani Sadr avrebbe auspicato, e che l'aggressione irachena avrebbe spostato definitivamente gli equilibri interni del Paese a favore dei religiosi, ponendo fine alle speranze di una rapida normalizzazione. Durante gli otto anni delle ostilità i loro settori più intransigenti avrebbero progressivamente conquistato la scena politica, anche per l'aperto sostegno dato agli iracheni da formazioni come i Mujaheddin del Popolo. La mancata condanna dell'invasione da parte della comunità internazionale avrebbe aggravato le condizioni di isolamento della Repubblica Islamica e la diplomazia iraniana avrebbe riferito proprio a Roma i possibili e assai problematici risvolti che la situazione sociopolitica di un Iran con le spalle al muro avrebbe potuto avere per i paesi europei. L'A. scrive anche della soluzione della crisi degli ostaggi nel gennaio del 1981 e del ritardo con cui da Roma avrebbero provveduto al conseguente alleviamento delle sanzioni. Nei mesi seguenti la diplomazia iraniana, sostenuta da un esecutivo che apprezzava la costanza con cui imprese e cittadini facenti capo allo stato che occupa la penisola italiana erano rimasti in Iran nonostante tutto, avrebbe cercato di ottenere da Roma la condanna dell'aggressione irachena. Non avrebbe ottenuto altro che vaghe garanzie circa "i buoni uffici per una soluzione negoziale" e qualche appena poco meglio fondata intenzione di impostare i rapporti con Tehran "sulla base di una disponibilità scevra da riserve mentali e da propositi di potenza". Secondo Milano lo stato che occupa la penisola italiana avrebbe diplomaticamente assunto una posizione equidistante, di fatto però aderendo a una politica di sostanziale appoggio all'Iraq anche nel capitolo della fornitura di armamenti. Una condotta che avrebbe reso oltremodo complicati i rapporti con il "più grande, più forte, più ricco e strategico" Iran. Nel corso del conflitto a Roma avrebbero chiuso entrambi gli occhi sulle triangolazioni che procuravano armi alla Repubblica Islamica durante una guerra in cui la allora CEE non seppe dare prova di coesione.
Il secondo capitolo del saggio inizia con una descrizione della politica, dell'economia e della società dell'Iran rivoluzionario. Nel 1981 l'impeachment di Bani Sadr e la successiva elezione di Khamenei avrebbero segnato la definitiva affermazione del Partito Rivoluzionario Islamico, agevolata anche dai devastanti attentati rivendicati dai Mujaheddin del Popolo. Khomeini avrebbe dimostrato una enorme capacità di mobilitazione con la formazione del corpo dei Basij -una "Forza di Resistenza e di Mobilitazione" messa alle dipendenze del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione- e con la denuncia della propensione al compromesso con l'Iraq mostrata da Bani Sadr. Khamenei sarebbe diventato Presidente della Repubblica nell'ottobre 1981, sancendo anche in via formale il controllo del Partito Rivoluzionario Islamico sulle istituzioni del Paese. Milano ricorda come nello stesso periodo l'Iran avrebbe evitato il tracollo grazie ai rialzi dei prezzi decisi dall'OPEC che avrebbero reso nuovamente competitivo il petrolio iraniano, e di come le imprese del gruppo ENI avrebbero nel peggiore dei casi evitato gravi rimesse, e nel migliore concluso vantaggiosi affari.
92 All'inizio degli anni Ottanta lo stato che occupa la penisola italiana avrebbe partecipato alla forza multinazionale intervenuta in Libano come elemento di interposizione a sostegno di una soluzione politica della guerra civile, cercando in questo modo di uscire dalla marginalità e di guadagnare margini di autonomia diplomatica da spendere -tramite l'ambasciatore Francesco Mezzalama- anche per la difesa dei corposi interessi nella Repubblica Islamica dell'Iran, come i cantieri aperti per il porto di Bandar Abbas. Milano tratta anche l'argomento delle molte migliaia di studenti iraniani presenti nella penisola italiana -alimentate anche dalla chiusura delle università in Iran- dapprima generalmente favorevoli alla rivoluzione e poi profondamente divisi tra sostenitori di Khomeini e suoi detrattori. La Repubblica Islamica avrebbe favorito la costituzione di una propria rete studentesca in contrapposizione a quella animata dai Fedayyin del Popolo, per controllare gli oppositori e favorire il consolidamento della rivoluzione. Tutto questo avrebbe comportato difficoltà di vario genere per lo stato che occupa la penisola italiana; dalle contestazioni per le politiche sui permessi di soggiorno agli scontri di piazza tra fazioni opposte.
Milano affronta il tema della politica interna in Iran nel 1982-83, caratterizzato dal perdurare dello stato di guerra e della sostanziale fine dello scontro tra forze di orientamento politico diverso, che avrebbe lasciato il posto a un confronto tutto interno al Partito Rivoluzionario Islamico sulla definizione finale dell'architettura delle istituzioni. Il risultato sarebbe stato un progetto di stabilizzazione sostanzialmente moderato e centralista, frutto di una mai scontata convergenza tra sostenitori di Khomeini e quietisti conservatori. La diplomazia risultante avrebbe rispecchiato la divisione tra progressisti -antioccidentali e antisovietici- e moderati convinti che la minaccia maggiore fosse data dai sovietici e che sarebbero progressivamente (e soprattutto segretamente) giunti a un compromesso con il Grande Satana. Con Roma la diplomazia si sarebbe avvalsa dell'impegno di giovani pragmatici di formazione occidentale e avrebbe cercato di legare il ritiro di quantitativi sempre maggiori di petrolio da parte dell'Agip all'effettiva esecuzione dei contratti in essere con l'Iran, in parte rallentati da problemi legati al recupero dei crediti e in parte fermi -specie per le forniture militari- per volontà politica più o meno esplicita. Su questo punto la diplomazia iraniana avrebbe fatto esplicitamente capire che nei futuri progetti di sviluppo del Paese avrebbe coinvolto solo coloro che avessero sostenuto lo sforzo bellico, rimarcato la presenza nella penisola di un buon numero di oppositori accusati di sanguinosi attentati in patria.
Nei primi anni Ottanta, nonostante l'anestesia imposta alle istanze più di sinistra, in Iran si sarebbe affermato un modello di spesa redistributiva su modello clientelare in grado di mantenere il consenso e la mobilitazione continua delle masse. La controffensiva contro l'Iraq del 1982 avrebbe costituito anche un tentativo di esportare la rivoluzione sciita; la sua avversione dal partito Tudeh sarebbe stata l'occasione per una rottura definitiva tra di esso e il blocco sociale moderato e conservatore, preludio alla liquidazione di un partito colpito da insistenti accuse di intelligenza col nemico e di attività controrivoluzionarie. Nonostante l'aperto atteggiamento antisovietico di Khomeini, i rapporti con l'URSS non sarebbero mai arrivati a gravi incidenti diplomatici o militari; nella penisola italiana la distruzione del Tudeh avrebbe spostato verso l'Iraq le simpatie della sinistra istituzionale, già molto critica da anni verso l'esecutivo di Tehran. In politica estera Tehran avrebbe iniziato l'invio di combattenti in Libano e diretto i gruppi sciiti all'estero, mescolando lotta armata e soft power. Nel corso degli anni il prestigio e gli effettivi dei Guardiani della Rivoluzione Islamica sarebbero aumentati considerevolmente, anche grazie alla disponibilità di un corpo di pronto impiego all'estero noto come Forze al Quds, fino a consentirgli di prendere il controllo di vari settori dell'economia. Milano sottolinea come l'intransigenza sul piano interno, specie a spese dell'autonomismo curdo, si accompagnasse al rifiuto di una pace di compromesso motivato anche dal rifiuto dell'ONU di riconoscere all'Iraq il ruolo di aggressore. Un eventuale successo iraniano avrebbe fatto traballare Saddam Hussein causando un effetto domino dalle conseguenze imprevedibili che avrebbe lasciato molto spazio all'iniziativa sovietica; gli USA avrebbero chiesto alla diplomazia europea di schierarsi con Baghdad ottenendo tiepidissimi riscontri. L'A. sottolinea come durante le offensive del 1983 la Repubblica Islamica dell'Iran avrebbe potuto contare solo sul sostego militare siriano, libico e nordcoreano, laddove l'Iraq avrebbe potuto contare su tutti i produttori di armi "dell'Est e dell'Ovest", compresi gli USA che avrebbero agito tramite Paesi terzi come il Kuwait, la Giordania e l'Arabia Saudita. Milano riporta come il timore del collasso di uno dei due contendenti avrebbe spinto gli USA ad una politica ambigua, contribuendo all'impegno militare di entrambi; in modo semi ufficioso per l'Iraq, in modo clandestino per l'Iran (con lo scandalo Iran-Contras).
Nel 1983, peggiorati i rapporti con l'OPEC e con le infrastrutture petrolifere molto danneggiate dai bombardamenti, la Repubblica Islamica avrebbe fatto ulteriori tentativi perché lo stato che occupa la penisola italiana superasse la neutralità nel conflitto e concretizzasse progetti con il coinvolgimento di propri operatori economici, cominciando con la riapertura di cantieri fermi dal 1979. Sarebbe stata trattata anche la fattibilità di un gasdotto verso l'Europa occidentale, e Milano scrive che nel corso degli anni la Agusta avrebbe trovato una "soluzione alternativa per onorare gli impegni" senza (o contro) il benestare della politica di Roma e di Washington, consegnando in qualche modo quanto pattuito alla Repubblica Islamica.
Milano descrive un fronte interno iraniano che nel 1983 sarebbe stato oltremodo problematico per qualsiasi investitore: una realtà in cui si sarebbero assommati normalizzazione sanguinosa, guerra, burocrazia indecifrabile, rapidi avvicendamenti ai vertici dei ministeri e incertezza politica. L'A. scrive anche di come il sempre più aperto sostegno di Washington all'Iraq dopo un attentato contro soldati statuitensi in Libano nel gennaio del 1984 avebbe esteso le ostilità agli obiettivi civili da parte di entrambi i contendenti e di come l'Iraq avrebbe fatto ricorso in misura crescente alle armi chimiche. L'Iran avrebbe invece preso ad attaccare navi sospettate di trasportare petrolio iracheno o armi dirette in Iraq, segnando una estensione del conflitto a tutto il Golfo Persico. L'A. scrive di come le misure di limitazione all'invio di armamenti decise a quel punto dai paesi europei avrebbero vanificato gli sforzi della diplomazia iraniana di uscire dall'isolamento puntando ai paesi occidentali, inducendola a cercare sbocchi verso i paesi confinanti e verso la Repubblica Popolare Cinese. Il nuovo ambasciatore Giuseppe Baldocci avrebbe preso atto di come l'affermazione dell'egemonia moderata e conservatrice avrebbe imposto un modello di sviluppo concentrato sul contenimento dell'inflazione e sulle politiche di austerità, in un contesto in cui la guerra avrebbe assorbito circa il 30% della spesa in un bilancio molto dipendente dagli introiti petroliferi. Baldocci avrebbe considerato l'Iran un partner industriale promettente, stante la necessità di infrastrutture e di tecnologie che al di là della propaganda terzomondista lo avrebbero reso ancora fortemente dipendente dalle economie occidentali avanzate, e raccomandato il proseguimento dei rapporti diplomatici ed economici entro limiti tali da non generare problemi con l'opposizione all'estero.
Milano riporta gli sviluppi delle ostilità che nel 1985 avrebbero interessato navi e infrastrutture al punto da non poter più essere ignorati dalla comunità internazionale, nonostante vi fossero realtà propense a lasciar correre -come lo stato sionista- in modo da avvantaggiarsi dal dissanguamento dei contendenti. La Repubblica Islamica dell'Iran avrebbe continuato a rifiutare diktat e risoluzioni dell'ONU a meno di una condanna dell'Iraq come stato aggressore e della denuncia del suo ricorso alle armi chimiche. In entrambi i paesi la guerra totale avrebbe fatto il gioco del potere agevolando forsennate iniziative di repressione. La posizione intransigente sulla guerra avrebbe favorito la carriera di Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, un pragmatico che pur condividendo con i conservatori dell'allora presidente Khamenei l'intento di diffondere gli ideali della Rivoluzione nelle comunità sciite del Medio oriente avrebbe imposto maggiore realismo in politica estera avvicinando ulteriormente la Repubblica Islamica all'URSS. Nello stesso periodo nella penisola italiana il Primo Ministro Benedetto Craxi avrebbe cercato di stemperare -peraltro in misura minima- il dogmatismo filostatunitense dei suoi predecessori, sviluppando un ruolo da mediatore per i conflitti mediorientali in opposizione all'interventismo unilaterale degli USA. Le organizzazioni diplomatiche rimaste a Tehran nonostante tutto, come l'Istituto di Cultura, sarebbero servite al ministro degli esteri Giulio Andreotti per rafforzare una presenza mediatrice intesa anche come fine in sé, intanto che nella penisola continuavano gli scontri tra dissidenza iraniana e filogovernativi. Lo stesso scopo sarebbe stato perseguito durante il semestre di turno alla presidenza della CEE tra il gennaio e il giugno del 1985. Lo stato che occupa la penisola italiana avrebbe cercato di presentarsi a Iran e Iraq come "la potenza più conciliante tra quelle occidentali" sperando di poter contribuire alla risoluzione di un conflitto che rischiava di estendersi a tutta la regione. Solo nel 1986 l'ONU avrebbe confermato l'uso di armi chimiche da parte dell'Iraq tenendo conto della cosa nelle risoluzioni di condanna indirizzate ai due belligeranti. La Repubblica Islamica dell'Iran sarebbe sempre stata accusata dalla comunità internazionale di non accettare il cessate il fuoco incondizionato e di alimentare il conflitto, nonostante l'Iraq fosse stato l'aggressore che aveva anche esteso lo scontro alle città e al Golfo. Milano scrive che una vittoria in guerra avrebbe restituito al popoloso Iran un ruolo di primo piano in un OPEC sostanzialmente controllata dai sauditi; gli USA e lo stato sionista si sarebbero mossi in modo da ridimensionare le ambizioni iraniane e irachene e da trarre lucro dal reciproco logoramento, senza però arrivare alla sconfitta totale di uno dei due paesi per non lasciare margini di manovra all'URSS. L'A. descrive anche come la penisola italiana sarebbe diventata una delle centrali della produzione e della distribuzione delle armi dirette più o meno legalmente in varie aree critiche del Mediterraneo. Gli stretti legami tra economia e politica, tra pubblico e privato, tra lecito e illecito avrebbero privilegiato in essa gli interessi economici di un settore che avrebbe prodotto consenso elettorale e sostanziose tangenti a beneficio del sistema partitico. Accampare il segreto NATO sarebbe servito a evitare controlli parlamentari su traffici diretti in Paesi di destinazione fittizi.
Milano scrive con molti dettagli anche la storia di una grave crisi diplomatica con Tehran alla fine del 1986. Uno spettacolo satirico televisivo in cui veniva deriso Ruhullah Musavi Khomeini avrebbe causato reazioni furibonde in Iran. La Repubblica Islamica avrebbe espulso personale diplomatico, richiamato il proprio ambasciatore da Roma e ordinato la chiusura dell'Istituto di Cultura a Tehran accusando lo stato che occupa la penisola italiana di attività dirette a minare la legittimità della Rivoluzione. Nelle successive schermaglie un clandestino su una nave iraniana rimasta per questo bloccata a Genova da uno sciopero di solidarietà dei portuali si sarebbe visto rifiutare asilo politico da Roma dopo che alcuni uomini d'affari sarebbero stati di fatto sequestrati per ritorsione all'aeroporto di Tehran. Al di là dell'episodio specifico, Tehran avrebbe considerato la penisola italiana come la nuova sede delle forze controrivoluzionarie, in un Occidente sfacciatamente schierato con l'Iraq e che capiva solo il linguaggio della forza. Nella penisola italiana avrebbero effettivamente operato un "partito iraniano" coinvolgente l'attività del ministero delle partecipazioni statali e vari esponenti diplomatici e un "partito iracheno" cui avrebbero fatto capo vari funzionari del ministero degli esteri e del Partito Socialista; Milano rileva che le licenze di esportazione di materiali anche strategici sarebbero state molto sbilanciate a favore di Baghdad. Lo scandalo Irangate avrebbe gettato nello stesso periodo luce su un'altra realtà per lo meno imbarazzante sia per gli USA che per i loro più fedeli seguaci nella penisola italiana; navi con bandiera danese partite da Talamone avrebbero recapitato in Iran materiali militari provenienti da basi NATO. Con la regia del Mossad. L'A. scrive che a Roma i responsabili politici interessati avrebbero in ultima analisi sostenuto che nessun embargo sarebbe stato violato, dal momento che non ne era stato formalmente decretato uno.
Il saggio accenna a come nel 1987 l'estensione del conflitto perseguita dall'Iraq avrebbe portato a considerevoli danni al traffico mercantile nel Golfo Persico, con centinaia di navi attaccate per lo più dall'aeronautica irachena, e alla drastica riduzione delle capacità di esportazione di idrocarburi per la Repubblica Islamica. L'Iran avrebbe lanciato una serie di iniziative diplomatiche in Europa chiedendo alla CEE di assumere iniziative diplomatiche volte a far cessare gli attacchi contro le navi mercantili suscitando reazioni contrastanti. Nel luglio 1987 l'ONU avrebbe emesso la risoluzione 598 in cui per la prima volta si accennava alle responsabilità dell'aggressione; dopo anni di utilitarismo e di ostentata equidistanza la comuità internazionale -messa davanti alla prospettiva di un conflitto generalizzato- la avrebbe sottoscritta all'unanimità. Milano scrive che in un Iran piegato dal conflitto ma ancora determinato a vincerlo avrebbe prevalso la tendenza a temporeggiare, e che gli attacchi alle navi mercantili sarebbero rallentati solo con l'arrivo in zona di forze navali di paesi terzi e con la Operation Earnest Will da parte statunitense, che contemplava la nazionalizzazione delle petroliere del Kuwait. Allo stato che occupa la penisola italiana gli USA avrebbero chiesto formalmente di intervenire nel Golfo Persico con proprie navi dragamine nonostante il conflitto in corso, nonostante la decisione potesse alzare ulteriormente la tensione e senza che l'operazione avesse copertura aerea. Il ministro degli esteri Andreotti avrebbe resistito a lungo alle pressioni statunitensi; forte delle elezioni vinte nel giugno dello stesso anno, la Democrazia Cristiana avrebbe proposto invece di inquadrare l'invio in una missione ONU o in alternativa per conto dell'Unione Europea Occidentale nonostante il parere degli atlantisti più intransigenti. Secondo Milano i cacciamine sarebbero partiti per conto della UEO -con una politica poco convinta e con un'opinione pubblica contraria- solo dopo un attacco contro il mercantile Jolly Rubino, avvenuto nel settembre 1987. Il saggio tratta diffusamente delle contemporanee vicende della risoluzione 598 e sull'impegno diplomatico di Roma per indurre Tehran alla sua accettazione nonostante il crescente isolamento diplomatico di Tehran. Milano scrive che Giuseppe Baldocci avrebbe lasciato l'incarico a Tehran a Vittorio Amedeo Farinelli dopo aver constatato la cancellazione di ogni effettiva forma di opposizione interna in un Paese che la scomparsa di un ottantacinquenne Khomeini non avrebbe certo sovvertito, stante il clima di unità di intenti riscontrabile sulla gestione della guerra. Di contro, lo stato che occupa la penisola italiana sarebbe arrivato nonostante tutto a conservare rapporti "buoni e corretti" e suscettibili di ulteriore miglioramento anche presso la sospettosa dirigenza iraniana, nonostante la crisi dell'anno precedente. La Repubblica Islamica dell'Iran avrebbe di contro rifiutato ogni iniziativa diplomatica congiunta che non rispettasse la conditio sine qua non della colpevolezza irachena e avrebbe dato il via alla preparazione di un'ennesima offensiva sul terreno. Milano scrive che nel clima di "cooperazione" tra superpotenze -in pratica l'URSS avrebbe lasciato campo libero agli USA in tutto il settore- nell'aprile 1988 gli statunitensi avrebbero attaccato installazioni e navi iraniane nell'ambito dell'operazione Prayng Mantis determinando la sostanziale rinuncia iraniana alla guerra, stanti anche i rapidi rovesci sul terreno dei mesi successivi. Milano sottolinea la portata della decisione di Khomeini di affidare a un gruppo ristretto guidato da Rafsanjani, accusato di cedevolezza da studenti e Guardiani della Rivoluzione, la fase di transizione che il Paese avrebbe intrapreso dopo la sua morte. Tehran costretta alla difensiva su ogni fronte -specie dopo l'abbattimento di un proprio aereo civile ad opera di una portaerei statunitense- avrebbe considerato Roma e in particolare Giulio Andreotti i veri artefici di una via d'uscita onorevole dal conflitto. Khamenei e lo stesso Khomeini avrebbero accettato nel luglio del 1988 il "calice di veleno" della risoluzione 598. L'A. nota che a trattative in corso una missione diplomatica avrebbe non solo affrontato con Tehran il problema dei crediti per il porto di Bandar Abbas, ma ahce avviato una nuova fase nei rapporti internazionali tra due Paesi uniti quantomeno dall'interesse alla ricostruzione. In questa, la Repubblica Islamica dell'Iran avrebbe riconosciuto il ruolo che lo stato che occupa la penisola italiana aveva avuto nella sua mediazione con L'Occidente riconoscendogli una parte di primo piano. L'intento di Rafsanjani sarebbe stato quello di adottare nel lungo periodo un modello economico asiatico trasformando l'Iran in un'economia industriale orientata all'esportazione, retta dalla disponibilità di energia a basso costo; il saggio elenca vari casi in cui dopo il 1988 le società dell'ENI avrebbero ottenuto contratti e commesse, per contro proprio o in joint venture. Il potere e la base sociale dei fautori del pragmatismo non sarebbero stati scossi neppure dalla condanna di Salman Rushdie, ultimo atto con cui Khomeini avrebbe cercato di rendere accettabile agli esponenti più radicali della Repubblica un compromesso amaro.
Milano conclude ricordando come la scomparsa di Khomeini avrebbe lasciato il successore Khamenei e Rafsanjani a proseguire il lavoro di ricostruzione delle relazioni diplomatiche e a dirimere i contrasti nel mondo variegato e policentrico del clero sciita in un paese in cui la Rivoluzione era stata capace di sconfiggere lo Shah e Jimmy Carter, oltre che di resistere in una guerra contro mezzo mondo.
Negli anni successivi la diplomazia europea avrebbe potuto beneficiare del crollo dell'URSS e della definitiva espulsione degli statunitensi dal mercato iraniano; non sarebbero stati inutili, a Roma, i trent'anni di buoni rapporti bilaterali.
Rosario Milano - L'Italia e l'Iran di Khomeini (1979-1989), Firenze, Le Monnier 2020. 256pp.
