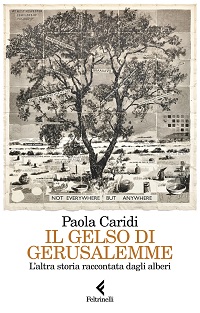
Paola Caridi scrive che l'elaborazione del testo -su cui sarebbe piombato l'attacco di Hamas contro lo stato sionista del 7 ottobre 2023- sarebbe iniziata nel 2020 durante l'isolamento forzato della quarantena e su ispirazione di uno scritto di Amitav Ghosh in cui un vulcano delle Molucche figura come artefice e come narratore della storia. Nel caso della Caridi, artefice e narratore della storia (in pratica lo spunto per la narrazione) è quanto rimane di un albero di gelso almeno centenario, in un cortile condominiale nel quartiere gerosolimitano di Musrara. Prima che qualcuno lo abbattesse senza alcuna formalità durante la pandemia, l'albero sarebbe stato un albero testimone del 1948 e della cacciata dei palestinesi dalla Gerusalemme Ovest annessa allo stato sionista. L'A. considera l'alberatura più o meno naturale, più o meno rilevante dei gelsi, dei lecci e dei sicomori, degli aranci, degli ulivi, dei carrubi, dei mandorli e delle palme come una testimone della storia mediorientale; il paesaggio di una regione che più di altre sarebbe adatta a descrivere gli esiti degli ultimi due secoli di colonialismo le appare come un qualcosa su cui "gli esseri umani hanno lavorato come se fosse una serra". Le piante e le alberature sono considerate dalla Caridi anche nel loro ruolo "di materie prime e merce, moneta sonante e parte a volte determinante dello sviluppo economico delle capitali coloniali". In tutta la narrazione le conseguenze della guerra iniziata il 7 ottobre 2023 vengono descritte nei loro effetti più distruttivi sulle persone, sulle cose e soprattutto sulla natura.
Il primo capitolo è sull'albero-piazza di molti insediamenti palestinesi vicini alla costa, il sicomoro di una Gaza storicamente descritta nella passata grandezza di snodo commerciale e di centro culturale monastico. Del fico sicomoro, ombroso e dai molti frutti, la Caridi ricorda con varie pagine di citazioni letterarie l'importanza di albero della vita nelle testimonianze di geografi e letterati, di cineasti e di storici e nei testi biblici, riportando alcuni dei moltissimi passi in cui viene citato. E ricorda la numerosità nella Gaza di un tempo, specie presso i santuari rurali chiamati maqam, prima che i piani di spartizione, le ondate di profughi, l'occupazione sionista, la cementificazione e un confine blindato stravolgessero anche questo aspetto della vita palestinese.
Nel secondo capitolo la Caridi tratta di Jaffa e dei suoi agrumeti. Le arance shamouti, remunerativo prodotto da esportazione da oltre centocinquant'anni e per vari decenni indispensabile antiscorbutico per la flotta britannica, negli anni compresi tra il XIX e il XX secolo sarebbero state una coltura da reddito la cui esportazione -incoraggiata dalla bassa imposta doganale- avrebbe permesso all'economia locale di prosperare e alla città di diventare il centro culturale della Palestina. L'A. scrive che le prime aliot avrebbero subito iniziato gli investimenti negli agrumeti, ampliandone ulteriormente l'estensione e arrivando a detenerne la maggior parte già nel 1929. Dopo il 1948 gli agrumeti avrebbero definitivamente cambiato di segno venendo risignificati e conservando la loro forza come simbolo di uno stato sionista che aveva urgente e grande bisogno di puntellare la propria identità soprattutto per quanto riguardava quel radicamento con la terra che era ragione stessa del sionismo. Il colore arancio sarebbe finito per diventare predominante nella comunicazione e nella propaganda dei coloni più irriducibili. L'A. ricorda il tema del "deserto che fiorisce" come uno dei più frequenti nella propaganda sionista fin dai tempi del Jewish National Fund, e gli alberi usati come simbolo di un paesaggio che deve descrivere lo stato sionista ed essere riconosciuto come proprio dai suoi cittadini, traducendo in modo letterale sul piano pratico l'espressione "mettere radici". Accanto all'appropriazione anche simbolica perseguita dai sionisti, l'A. ricorda l'uso della diaspora palestinese di ricordare uno sradicamento concreto, conservando sacchetti di terra delle località di origine. Secondo la Caridi dall'inizio del XX secolo il Jewish National Fund avrebbe piantumato grandi estensioni di conifere a crescita rapida per rendere non solo più verde e più familiare a uno sguardo europeo il territorio occupato dal colonialismo sionista, ma per sancire la conquista del paese con la trasformazione del paesaggio. Tra i risvolti problematici dell'intensissima opera di messa a dimora -scrive la Caridi- il fatto che le nuove alberature sarebbero servite al "greenwashing del conflitto" cancellando anche alla vista quanto rimaneva di molti villaggi palestinesi dopo il 1948; vestigia che tornerebbero visibili in seguito agli incendi boschivi, a testimoniare un passato che non passa. L'A. descrive poi la vicenda che ha portato alla costruzione della colonia sionista di Har Homa al posto di un bosco realizzato dal JNF a Abu Ghneim; disconnettere anche visivamente Gerusalemme da Betlemme e in genere dal resto della Cisgiordania -conclude- agli esecutivi sionisti deve essere sembrato più importante che far fiorire il deserto. La costruzione del muro in Cisgiordania invece avrebbe comportato, tra le altre cose, la rapida distruzione di ampie estensioni di uliveto e della vita sociale ed economica connessa, il cui segno sul paesaggio sarebbero stati i muri a secco estesi per centinaia di chilometri di terrazzamenti.
Il terzo capitolo torna ad occuparsi con maggiore dettaglio dell'albero di gelso, la cui fitta presenza in Palestina e in Libano lo avrebbe reso una delle piante più citate nella letteratura. La Caridi rileva la scomparsa dei gelsi -e più in generale dei giardini- dal quartiere gerosolimitano di Musrara e la loro sostituzione con una rete di strade e di superstrade come un ulteriore segno del controllo sionista del territorio, e descrive l'importanza del gelso per una industria della seta che il colonialismo francese avrebbe promosso a partire dalla metà del XIX secolo. In Libano il gelso sarebbe stato oggetto di una coltura intensiva che avrebbe tolto spazio alle colture alimentari, fino a concorrere con la prima guerra mondiale ad una "tempesta perfetta" -cui avrebbero contribuito meteorologia avversa, blocchi navali, requisizioni ed eventi bellici in generale- che avrebbe condannato all'inedia la popolazione libanese. La guerra della fame del 1914-1918 avrebbe dimezzato la popolazione di Beirut e provocato secondo le stime più ottimistiche trecentocinquantamila vittime.
Cancellata da Musrara, la vegetazione palestinese si sarebbe presa una rivincita nell'"isola dell'abbandono" di Lifta, piccolo borgo abbandonato dopo la Nakba e rimasto immobile nel tempo tra le cui case prospererebbero oggi i fichi d'India.
La Caridi ricorda nel quarto capitolo la lotta degli ecologisti turchi per impedire la distruzione dei platani orientali del parco Gezi nel 2013; in quelle circostanze la reazione violentissima della forza pubblica avrebbe trasformato la causa di poche decine di persone in quella di milioni di manifestanti. L'episodio, verificatosi in una Repubblica di Turchia interessata da uno "sviluppo" edilizio definito "neoliberismo del bulldozer", viene inquadrato dall'A. nell'ondata di istanze volte alla riappropriazione dello spazio urbano che avrebbe interessato i movimenti politici di base di molti paesi nel secondo decennio del ventunesimo secolo. Al Cairo gli alberi sarebbero invece le prime vittime di una trasformazione voluta dall'esecutivo per favorire la mobilità privata e l'apparato militare-industriale contiguo al potere, con la costruzione di una città contemporanea "postmoderna, sorvegliata fino all'ossessione, fatta di fili d'asfalto che portano gli automobilisti, ma solo alcuni fortunati e prescelti, al vero e proprio abitato al quale si accede solo in quanto residenti". La rimozione degli alberi punterebbe anche a securizzare e igienizzare ogni spazio pubblico facilitando ogni tipo di videosorveglianza e, all'occorrenza, il tiro dei cecchini.
L'uso sionista di impossessarsi della terra trasformandone il paesaggio e modificandone di proposito il tipo, la distribuzione e la collocazione delle specie vegetali è una variante specifica di una prassi coloniale vecchia di almeno tre secoli. L'ultimo capitolo del libro allarga quindi la prospettiva illustrando la botanica concepita in funzione dell'agricoltura coloniale. Prendendo spunto dall'erbario -in cui i campioni vegetali verrebbero separati dal loro contesto e archiviati secondo lo sguardo dello scienziato e dell'esploratore- e dalla storia e dalla funzione di istituzioni come i Kew Gardens londinesi, per decenni fulcro di una "botanica economica" in cui si osservava il comportamento delle piante in campi sperimentali prima di iniziarne la coltivazione nelle aree reputate le più produttive, il testo riprende la storia dell'orto botanico di Palermo, del giardino coloniale organizzatovi dal 1913, e dell'istituto agricolo coloniale di Firenze fondato nel 1908. La Caridi considera il "colonialismo botanico" tradotto operativamente in realizzazioni di quel tipo come mosso dallo stesso approccio della spedizione bonapartiana in Egitto: quello della riscrittura di una storia ad opera dei conquistatori. Le piante non native -come le pomelie o i mandarini, nel caso di Palermo- che hanno avuto fortuna nella trama urbana e nel paesaggio delle città occidentali vengono considerate dall'A. un punto di partenza per riconsiderare i paradigmi con cui viene rappresentata certa parte della storia.
Tra gli alberi voluti dallo stato sionista un ruolo del tutto peculiare spetterebbe a quelli del Giardino dei Giusti a Gerusalemme Ovest, ciascuno dei quali ricorda qualcuno che ha contribuito a salvare vite negli anni dello sterminio degli ebrei d'Europa. La Caridi dedica ad essi, e in particolare a quello dedicato alla famiglia dell'intellettuale cattolico e seguace di Giorgio la Pira Vittorio Citterich, le ultime pagine del suo libro. Pagine in cui l'A. ricorda anche i dieci anni trascorsi a vivere e a lavorare a Gerusalemme, le erbe del mercato alla Porta di Damasco vendute dalle palestinesi che non decidono niente e subiscono tutto, e un secondo albero guida. Un pino in un cimitero monastico sul monte Nebo che, a differenza del gelso di Musrara tagliato con "sciatta crudeltà", qualcuno aveva invece provveduto a proteggere.
Paola Caridi - Il gelso di Gerusalemme. L'altra storia raccontata dagli alberi. Feltrinelli, Milano 2024. 160 pp.
Paola Caridi - Il gelso di Gerusalemme. L'altra storia raccontata dagli alberi
- Visite: 25
