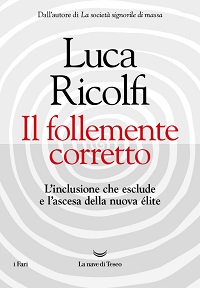
Luca Ricolfi teorizza l'esistenza di un follemente corretto come degenerazione del politicamente corretto presente nel linguaggio mediatico e politico a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso, e originariamente inteso come atto a promuovere la coesione sociale e il rispetto dei soggetti più deboli. Ricolfi presenta nella prima parte del libro una quarantina di vicende come esempi della fenomenologia di un follemente corretto che non intende ingabbiare in una definizione, stante anche una mutevolezza che fa propendere l'A. per sottolineare i meccanismi della sua propagazione e quindi del suo funzionamento, più che della sua essenza. Il follemente corretto avrebbe promosso l'ascesa di due categorie, quella delle vestali della Neolingua e quella delle lobby del Bene, che cercherebbero di imporre il proprio punto di vista "in nome di qualche causa ritenuta superiore e indiscutibile", perorare la quale si tradurrebbe in un'attenzione ossessiva per la correttezza del linguaggio e per "le più improbabili rivendicazioni delle minoranze sessuali". Nei mass media e nella comunicazione in generale, l'adesione al follemente corretto avrebbe comportato la perdita del senso delle proporzioni e della capacità di distinguere i grandi problemi sociali da quelli "decisamente minori, o largamente soggettivi, o artificialmente amplificati". Nella seconda parte del libro l'A. mostra in che modo l'adozione del follemente corretto avrebbe ampliato la distanza tra i ceti istruiti, ipersensibili alle questioni del linguaggio e alle battaglie per i diritti civili, e i ceti popolari esposti a una continua erosione dei diritti sociali più elementari.
Il primo capitolo tratta della guerra dei pronomi e dei suoi distorti esiti, che nella lingua inglese (soprattutto in ambito accademico) contemplerebbero una proliferazione di pronomi più o meno cervelloticamente declinati e la cui scelta è arbitraria e soggettiva: ciascuno sceglierebbe liberamente con quale pronome gli altri dovrebbero obbligatoriamente chiamarlo, e lo dichiarerebbe nelle prime battute di qualsiasi conversazione. Il tutto sotto la capziosa sorveglianza di organizzazioni prive di qualsiasi mandato collettivo.
Negli stessi ambiti accademici sarebbe diventato problematico definire qualcuno cieco e nano, anche in un articolo scientifico dove ad essere cieca è la selezione naturale e a essere nani sono gli elefanti estinti delle isole del Mediterraneo.
Il linguaggio politicamente corretto imporrebbe un alto numero di prescrizioni suscettibili di vincolare, limitare e impoverire la scrittura; l'ampio sfoggio di asterischi, schwa e artifici volti a includere e a non offendere configurerebbe una sorta di "bullismo etico" veicolato da una sperimentazione linguistica oggi dotata di tutti i mezzi per propagarsi e imporsi, facendo miriadi di propagatori suscettibili a loro volta di comportarsi da censori nei confronti di chi non si converte al suo utilizzo. Le scelte linguistiche verrebbero quindi valutate non sul piano dello stile, ma su quello dell'etica e della morale.
Sui voli Lufthansa un secco Guten Tag avrebbe sostituito una formula di benvenuto rivolta a Damen und Herren per evitare critiche a nome di chi non si sente né Dame né Herr. Tanta squisita delicatezza eviterebbe anche di impegnarsi per fornire qualche comodità in più o code meno lunghe all'imbarco.
Il follemente corretto sarebbe propenso a vedere sessismo, razzismo e discriminazione anche nel modo con cui ci si riferisce ad oggetti inanimati: bandire le definizioni di "maschio" e "femmina" o di "slave" e "master" in campo tecnico assicurerebbe approvazione da parte dei suoi miliziani assai più che affrontare problemi concreti come i salari o le condizioni di lavoro: "la sorveglianza sulla correttezza del linguaggio deve essere totale, la punizione e rieducazione dei reprobi devono essere puntuali e sistematiche".
Ricolfi ricorda la prassi, entrata nell'uso da qualche anno soprattutto negli ambienti scolastici, di evitare riferimenti alle feste cristiane col pretesto di non offendere la sensibilità islamica; si chiede se sia vero che i musulmani si offendono, trovando buone ragioni per essere convinto del contrario. E per asserire che in Occidente si starebbe affacciando una generazione insicura, ansiosa, narcisista, emotivamente fragile, suscettibile, poco resiliente e ancor meno capace di confrontarsi con opinioni diverse, frutto di genitori sostanzialmente incapaci di educare.
Una delle prime manifestazioni del follemente corretto, scrive Ricolfi, andrebbe identificata nell'uso del trigger warning nelle università statunitensi, ovvero l'uso di avvertire gli astanti prima di far riferimento a opere dal contenuto poco corretto. Secondo l'A. neppure attenersi scrupolosamente a questa prassi permetterebbe di tutelarsi da eventuali e legalissime ritorsioni che -trattandosi degli USA- possono allegramente arrivare al licenziamento.
La parola donna sarebbe anch'essa diventata di uso problematico; dal 2019 nel Regno Unito sarebbe invalso l'uso, soprattutto nelle publicità o nelle linee guida per determinati servizi medici, di ricorrere elaborate perifrasi per non urtare la sensibilità di nessuno. Salvo irritare chi non ha suscettibilità particolari. Anche in questo caso secondo Ricolfi il potere intimidatorio dei "guardiani della lingua" andrebbe a tutto detrimento della libertà di chi scrive.
Nel Regno Unito la docente universitaria Kathleen Stock, Ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico per meriti accademici, femminista e lesbica, sarebbe stata costretta alle dimissioni nel 2021 con lo stigma di transfobica per aver sostenuto che la biologia conta e che "sono donne solo le persone biologicamente tali". Secondo Ricolfi -che arriva a condividere una traduzione operativa della "libertà di parola" con cui concorderebbero i più abietti propagandisti "occidentali"- le frange più radicali dell'attivismo LGBT+ non tollererebbero che delle donne contraddicano quanto sostenuto dai segmenti più estremi del movimento, arrivando al paradosso di un attacco alla libertà delle donne -tradizionalmente descritte come discriminate- in nome dei diritti di una minoranza discriminata a sua volta. Secondo l'A. un provocatorio saggio filosofico del 2017 in cui Rebecca Tuvel avallava l'ammissibilità del cambiare razza -dal momento che tra una transizione di razza e una transizione di genere non sussisterebbero differenze tali da autorizzarne una piuttosto che un'altra- avrebbe levato le ire degli stessi ambienti.
Il mondo dell'arte, scrive Ricolfi, sarebbe la vittima più illustre di un follemente corretto che ha inquadrato nel proprio mirino migliaia di opere politicamente scorrette, che in generale verrebbero "rimosse dal canone" o ritirate dal commercio. L'A. cita comunque casi di opere modificate, nel titolo o nel contenuto "come se l'arte avesse fini pedagogici e ai posteri fosse lecito usurpare gli autori classici riscrivendo più o meno liberamente i loro testi", sottolineando l'imperversare delle manipolazioni nel campo della letteratura per ragazzi. Ricolfi scrive di come l'opera di Roald Dahl sarebbe stata vagliata da una società -la Inclusive Minds- specializzata nella "normalizzazione" del linguaggio, che sarebbe intervenuta decaratterizzando personaggi e situazioni.
La correttezza politica si mostrerebbe tanto più invasiva quanto minore è la neutralità intrinseca di un ambito culturale. Difficile fare inferenze sulla correttezza politica di una legge fisica o di un teorema, facile farne in contesti come quello delle discipine umanistiche o delle arti figurative. Ricolfi considera il campo della musica classica, in cui -in un climax di assurdità- la censura inizierebbe col colpire Le petit nègre di Debussy e finirebbe con considerare colpevoli di razzismo tutti i compositori e musicisti occidentali in quanto bianchi. Ricolfi si sofferma in particolare sulle accuse di razzismo mosse (molto postumamente) a Debussy in ambiente statunitense.
Ricolfi rileva anche il diffondersi della pretesa di giudicare opere del passato in base alla vita dei loro autori, minuziosamente passata in rassegna secondo i criteri di una sorta di femminismo retroattivo. A farne le spese, tra gli altri, Paul Gauguin, Indro Montanelli, Pablo Neruda.
La correttezza poitica riuscirebbe a "scalare vette impensabili di stupidità"; Ricolfi ricorda a questo proposito le furibonde invettive che avrebbero accolto il blackfacing, ovvero il truccare di scuro il viso di attori chiamati a interpretare in teatro ruoli come quello di Aida o di Otello. L'accusa di razzismo avrebbe un potere intimidatorio straordinario al punto cha indurre chiunque la subisca a fornire giustificazioni, dimenticando che il teatro è finzione nella sua interezza.
Luca Ricolfi ricorda i limiti intrinseci a certi tentativi di allargare l'elenco delle azioni discriminatorie sanzionabili, rappresentati dal fatto che le categorie e le condizioni passibili di ostilità, di discriminazioni e di bullismo sarebbero potenzialmente infinite. La difesa politicamente corretta dei sovrappeso, nota sarcasticamente l'A., sarebbe arrivata al punto di produrre e di diffondere una rivalutazione della loro immagine positiva al punto da mettere in difficoltà medici e nutrizionisti.
Nella descrizione dell'operato dei "legislatori del linguaggio", sempre più numerosi e per lo più autonominati, l'A. non sempre riesce a mantenersi serio: per metterli tutti d'accordo ed evitare il ricorso al vocabolo normale, malvisto in numerosi contesti perché implicherebbe una qualche anormalità altrui, Ricolfi si fa prendere la mano dalle perifrasi ipercorrette arrivando a suggerire l'uso di TAB, temporarily able-bodied. Temporaneamente equipaggiato con un corpo abile.
Sulla questione del femminismo contemporaneo, Ricolfi rileva l'adozione e l'estensione fino ad esiti paradossali del concetto di intersezionalità presentato da Kimberlé Crenshaw per denunciare l'insufficienza di strumenti legali chiamati a fornire tutela a combinazioni multiple di oppressione e svantaggio. Col passare degli anni si sarebbero affermate interpretazioni sempre più aggressive e politicizzate del concetto che enfatizzerebbero le dimensioni geopolitiche dell'oppressione contrapponendo le donne bianche, occidentali e benestanti alle donne che si trovano in condizioni opposte. La progressiva sovrapposizione della difesa di tutto ciò che esce dal binarismo di genere a fronte della tradizionale difesa di lesbiche e gay avrebbe invece portato ad un avanzamento in agenda delle priorità dei transessuali. Nello strutturarsi attorno a una scala di oppressione (dominata da donne di colore, lesbiche, poco istruite e non occidentali) e ad una scala di privilegio in cui si trovano donne bianche, benestanti, eterosessuali, occidentali in generale e sioniste in particolare, il femminismo avrebbe perso il proprio universalismo originario. L'A. nota che la pretesa neanche molto dissimulata sarebbe oggi quella di assegnare pesi e dignità diversi alle rivendicazioni di categorie diverse. I distinguo coinvolgerebbero anche lo status dei maschi oppressori: sempre da condannare se bianchi ed eterosessuali, gravati da minori colpe se non occidentali e quindi presunte vittime dei bianchi a loro volta. Ricolfi cosidera l'antisemitismo una costituente essenziale del "transfemminismo" contemporaneo, il che sarebbe fondato intendendo il vocabolo come lo intende la "libera informazione", in cui è antisemita (e dunque reo di nostalgie inconfessabili) chiunque eccepisca un qualsiasi aspetto della vita associata, culturale e politica dello stato sionista. In contesti più seri il movimento transfemminista viene assai più correttamente considerato antisionista, caratteristica che lo accomuna peraltro a moltissimi movimenti di piazza.
La "autodeterminazione di genere" già legge in alcune realtà viene portata dall'A. ad esempio dello sbilanciamento dell'agenda politica in favore delle priorità dei transessuali: sentirsi e identificarsi come femmine sarebbe sufficiente per usufruire di diritti e soprattutto di spazi un tempo riservati alle donne. Secondo l'A. considerare inesistente il sesso biologico e propendere invece per innumerevoli stati intermedi porrebbe più problemi di quanti ne risolva; l'aumento del peso demografico delle persone transessuali porrebbe comunque il problema di adottare dei criteri di inclusione in terreni come quello delle competizioni sportive.
Ricolfi critica da sociologo la nozione di patriarcato perché priva di una definizione operativa che permetta di stabilire se e quanto una società o un individuo siano patriarcali, soprattutto nelle società occidentali in cui da tempo sarebbe venuto meno quel principio di autorità che delle culture patriarcali sarebbe un elemento insostituibile. Riconosce invece come tutt'altro che scomparso il maschilismo, contro il quale sarebbero meglio e più costruttivamente dirette iniziative ed invettive.
Per chi si interessa delle vicende del politicamente corretto gli Stati Uniti si presenterebbero, specie negli ambienti accademici, come "una insostituibile miniera di follie". L'A. ripercorre la vicenda di Andrea Berto alla Michigan University, che per molti anni avrebbe usato il film 300 per mostrare agli studenti di storia in che modo il passato possa essere deformato dalle idee contemporanee prima di essere denunciato presso l'amministrazione universitaria da alcune studentesse "evidentemente incapaci di prendere le distanze da un film-fumetto". Dalle università statunitensi si sarebbe diffusa anche l'attenzione per "diversità, equità e inclusione" di cui l'A. passa in rassegna alcuni tra gli esiti più astrusi, controproducenti o semplicemente ridicoli. Nella "cultura woke", in cui i maschi bianchi eterosessuali sarebbero visti come dei privilegiati colpevolmente inconsapevoli del passato coloniale e schiavista dell'uomo bianco, l'intenzione di sconfiggere le discriminazioni con l'uguaglianza sarebbe stata sostituita dalla pretesa di imporre l'uguaglianza attraverso le discriminazioni. La correttezza politica nel mondo culturale e mediatico statunitense sarebbe arrivata al punto di imporre una sorta di aprioristica presunzione di colpevolezza; discriminazione e razzismo ubiqui e connaturati al sistema renderebbero tutti colpevoli fino a prova contraria. Non prendere posizione nel modo giusto comporterebbe rappresaglie sottoforma di emarginazione o di cali del fatturato.
Nel mondo anglosassone le già accennate questioni linguistiche sui pronomi e sulle relative preferenze avrebbero dato origine a una sorta di galateo spasmodicamente attento alla sensibilità individuale e diffuso tra i ceti medio alti, dei quali sarebbe diventato un biglietto da visita in grado di accentuarne la separazione e la alterità rispetto al resto della popolazione.
Secondo l'A. l'attenzione del mondo progressista si sarebbe spostata negli ultimi decenni dai grandi gruppi sociali rappresentati dagli operai e dalle donne a gruppi minoritari come le minoranze sessuali, anche per l'affermarsi di un modello di "società signorile di massa" basata sulla ostentazione dei consumi e sull'ossessione per il sesso. Dopo aver fatto ironia sul costante allungarsi degli acronimi a inclusione, Ricolfi rileva che il concetto di identità da tutelare tenderebbe a modificarsi fino a comprendere non solo quello che un individuo è, ma anche quello che esso fa, a prescindere da come gli altri lo percepiscono o lo giudicano. Secondo l'A. la cultura woke sarebbe profondamente diversa dal femminismo storico perché non proporrebbe alcun codice di comportamento condiviso dalla maggior parte delle donne e si concentrerebbe invece sulla capziosa rassegna dei comportamenti maschili in cerca di tracce anche impercettibili di atteggiamenti "patriarcali, sessisti, discriminatori, disturbanti, offensivi" definiti come tali da "autoproclamate vestali" o secondo "gli imperscrutabili vissuti interiori di chiunque si proclami vittima di molestie, offese, microaggressioni, turbamenti della propria sensibilità". Anche le innovazioni linguistiche sarebbero dovute a cambiamenti pilotati spesso frutto di scelte arbitrarie di una qualche élite intenzionata ad accrescere il proprio status morale facendo sentire inadeguati quanti non le approvassero o non le condividessero. Ricolfi è convinto che moltissime persone abbiano ben altri problemi da affrontare e che non siano certo felici "di essere guardate dall'alto in basso dai riformatori del linguaggio"; non nasconde la sua approvazione per quanti decidono di mettere al bando asterischi, schwa e ogni altro artificio inclusivo per tornare al "maschile sovraesteso", prima di illustrare nel dettaglio i quattordici modi di rivolgersi a tutti in modo neutro fino a oggi proposti nella penisola italiana. Perfidamente, Ricolfi nota che l'inclusività non avrebbe impedito all'ateneo di Trento -che nel nuovo regolamento generale presenterebbe solo forme femminili- di trovarsi con un rettore uomo e con i conti in rosso, serio problema per qualsiasi politica di inclusione autentica.
Ricolfi ricorda come negli Stati Uniti l'autocensura sarebbe arrivata a interessare anche banche e istituzioni finanziarie, capacissime di negare l'accesso ai propri servizi a chiunque in virtù di un giudizio etico di fatto insindacabile, formulato sull'analisi sistematica delle transazioni. L'A. nota che il Primo Emendamento della Costituzione statunitense garantisce sì libertà di parola, ma solo rispetto alle interferenze del Congresso, lasciando le mani libere alla contrattualistica privata.
Con la breve descrizione della parabola dell'organizzazione britannica Stonewall Ricolfi si addentra in una tassonomia delle organizzazioni interessate alla difesa delle minoranze sessuali, rilevando la recentissima ascesa di movimenti contrari ai percepiti eccessi dell'attivismo. L'estrema apertura del governo scozzese verso le istanze più radicali e verso gli esiti controproducenti della loro traduzione in legge, ricorda l'A., sarebbe stata accolta da ondate di critiche tali da portare alla caduta dell'esecutivo. Per casi del genere, l'A. chiama in causa una distorsione percettiva che porterebbe a considerare gli attivisti più importanti del corpo elettorale.
Negli Stati Uniti le versioni estreme del politicamente corretto avrebbero pesantemente influenzato il linguaggio -sottoposto a una completa e grottesca sterilizzazione- gli scopi delle istituzioni culturali -chiamate a scopi che non sono la conoscenza, la ricerca della verità, il dialogo e l'obiettività- il reclutamento e le carriere. Uno stato di cose che avrebbe effetti seri anche sulla creatività e sulla qualità delle opere letterarie e artistiche. Secondo Luca Ricolfi sarebbe la stessa pretesa di detenere il monopolio del giusto a levare reazioni che non solo contrastano la diffusione, ma minano il prestigio del politicamente corretto. L'A. è convinto dell'esistenza di una vera e propria lobby trans -avvantaggiata per anni da una grossa visibilità mediatica- il cui operato avrebbe portato all'innesco delle crisi di rigetto più serie. Negli Stati Uniti invece reazioni dello stesso genere sarebbero state in pochi anni il risultato della sostanziale imposizione di protocolli e pratiche aziendali (non certo a costo zero) volti a favorire "diversity, equity and inclusion". Secondo Ricolfi l'agenda DEI comporterebbe l'adesione a una visione del mondo basata sulla colpevolizzazione dei bianchi, sull'ossessione per il "razzismo sistemico" e la difesa a oltranza del politicamente corretto; uno stato di cose che avrebbe tirato la volata al candidato Donald Trump alle elezioni presidenziali del 2024, così come la legislazione favorevole al "self-id" (l'autoattribuzione del genere) avrebbe giocato contro i partiti progressisti nell'Unione Europea.
All'inizio della seconda parte del libro l'A. tenta di definire il follemente corretto come "forma estrema di costrizione linguistica" dagli echi orwelliani. Con la differenza che l'idea di alterare il pensiero modificando il linguaggio in cui Orwell avrebbe visto una minaccia mortale alla libertà oggi sarebbe considerata una risorsa per ampliare i diritti individuali e promuovere la giustizia sociale. L'ascesa del follemente corretto sarebbe dovuta allo sviluppo dell'infrastruttura informatica e comunicativa che ne assicura la circolazione, con particolare riguardo alle "reti sociali". I contenuti derivanti da un politicamente corretto esistente da decenni si sarebbero avvalsi della propagazione del potenziale intimidatorio che caratterizzerebbe i nuovi media: in essi ogni comunicazione sarebbe soggetta a rischio di contestazioni tanto pesanti quanto difficili da arginare e dal potenziale di espansione pressoché illimitato. Contestazioni che sarebbero dirette non contro azioni o opinioni, ma contro il linguaggio utilizzato; secondo Ricolfi nel politicamente corretto non ci troveremmo davanti al noto fenomeno per cui una minoranza consistente persevera nel proprio comportamento fino a indurre la maggioranza ad adeguarsi, ma a una realtà in cui una minoranza pretenderebbe di alterare il linguaggio della maggioranza emettendo valutazioni etiche in base agli esiti di questa imposizione. Dato il funzionamento delle "reti sociali", che è privo di filtri autenticamente selettivi, sarebbe sufficiente raggiungere la massa critica per innescare conseguenze non solo telematiche per i destinatari della censura. In un simile contesto sarebbe possibile far decollare campagne di ogni tipo, contro chicchessia, senza alcuna delega o legittimazione alle spalle. Tra gli esiti di chi si percepisce come potenziale obiettivo l'adozione del follemente corretto anche per mero opportunismo, che si tradurrebbe nell'adozione di un linguaggio "povero, formale, asettico, artificioso e soprattutto privo di ogni colore ed espressività".
Secondo Ricolfi, letteratura alla mano, il web avrebbe contribuito alla costruzione di una realtà psichica nuova tramite l'apertura di confronti continui e competitivi; la conseguente insicurezza verrebbe ulteriormente amplificata dalla diffusione di contenuti in grado di instillare dubbi. Altri contenuti ancora sarebbero invece in grado di alimentare svariati (e anche strampalati) vissuti vittimistici: l'A. considera come caratteristica dello stato di cose presenti la tendenza a spostare "sempre più in là il confine fra i normali incidenti della vita e i traumi di cui si sarebbe le vittime indifese", accompagnata da una psicologizzazione (e medicalizzazione) di ogni aspetto della vita quotidiana. Il web e le "reti sociali" avrebbero oltremodo amplificato la tendenza alla suscettibilità e soprattutto agevolato la trasformazione di situazioni ordinarie in veri e propri drammi, al punto che qualsiasi disagio soggettivo verrebbe considerato nelle realtà più ligie al follemente corretto come il risultato di una qualche microaggressione. A questo proposito, Internet conierebbe instancabilmente nuovi vocaboli per codificare possibili occorrenze di comportamenti politicamente scorretti da additare all'esecrazione generale; le situazioni etichettabili e demonizzabili sarebbero potenzialmente infinite.
Nel campo delle produzioni artistiche la reale o ipotetica ipersensibilità del pubblico restringerebbe molto i modi di significare le cose, facendo tendere tutto all'insipido; satira e comicità, basate sulla più o meno spietata messa in evidenza di debolezze e fragilità, ne sarebbero pressoché annullate. Il follemente corretto presupporrebbe l'impossibilità di contestualizzare, di distinguere le sfumature di significato e il letterale dal metaforico, oltre a una propensione a reagire in modo pavloviano.
La destra "occidentale" avrebbe fatto da tempo un bersaglio delle assurdità del politicamente corretto, cosa che avrebbe prodotto dividendi elettorali molto cospicui soprattutto nell'elettorato propenso a ignorare i dettami del politicamente corretto, ricevendone in cambio il disprezzo di una élite più o meno illuminata. Secondo Ricolfi questo non indicherebbe l'assenza di voci dissenzienti, nonostante un'area del non-dicibile in continua espansione. A rendere difficile la resistenza sarebbero la bontà delle intenzioni dichiarate, la greve ostilità preconcetta e demonizzante con cui la destra bolla l'intera questione e in ultimo la capacità del follemente corretto di creare continuamente nuove versioni di se stesso. Una sua istanza iniziale ragionevole tenderebbe a replicarsi, diventandolo man mano sempre meno. Progetto totale, il follemente corretto moltiplicherebbe vocaboli proibiti, categorie protette e ambiti di applicazione.
Secondo Luca Ricolfi il follemente corretto non si limiterebbe a influire sulla lingua, ma modificherebbe i rapporti sociali in modo radicale perché sarebbe lo strumento di affermazione di una nuova élite in grado di valutare in modo occhiuto l'adesione ai suoi stessi dettami e di decretare il successo o il fallimento di qualsiasi iniziativa con la semplice arma del boicottaggio e della denigrazione. Come già detto l'A. teorizza l'esistenza di una nuova élite composta dalle "vestali della Neolingua" addette alla sterilizzazione del linguaggio, dalla "lobby del Bene" addetta a imporre correctness a gruppi e organizzazioni, e anche dalle "guardie rosse della diversity" che sovrintenderebbero al rispetto dei principi di diversity, equity and inclusion. Le tre componenti si avvarrebbero di una base di vigilantes instancabilmente all'opera sul web per distribuire "pagelle, invettive e lodi sperticate a seconda dei contenuti che incrociano". La loro mera esistenza sarebbe sufficiente a tenere sotto tiro chiunque comunichi in rete, permettendo di amplificare ogni minimo episodio.
L'impatto del follemente corretto sulla società nel suo insieme avrebbe come risultato "una maionese impazzita che esalta tutti i contrasti preesistenti", a cominciare da quello tra ceti acculturati e ceti popolari, minando alla radice le basi stesse della coesione sociale. Questo non lo renderebbe privo di falle logiche, prima tra tutte l'assenza di vincoli logici o semantici nella catena di associazioni che rende man mano inammissibili comportamenti sempre nuovi, e che sarebbero spesso lasciate all'arbitrio di riformatori per lo più autonominati. La seconda falla sarebbe la mancanza di limiti definiti a stabilire il perimetro della protezione; nessun criterio apparente consentirebbe di distinguere le categorie meritevoli di tutela. In terzo luogo, il follemente corretto non sarebbe in grado di impedire i conflitti che la protezione di determinate minoranze potrebbe suscitare. Infine, se visto come ultima tappa di un processo storico di sostituzione dei diritti sociali con i ben meno costosi diritti civili, il follemente corretto si muoverebbe come se ogni desiderio potesse dare luogo a un diritto e come se ogni diritto così proclamato non avesse alcun costo né in termini economici né in termini di diritti altrui.
Nella sinistra contemporanea, riflette Ricolfi, il follemente corretto apparirebbe al tempo stesso come un caposaldo e come un fattore di debolezza. Esso avrebbe consegnato alla destra la bandiera della libertà d'espressione e soprattutto alimenterebbe gravemente il baratro culturale e psicologico tra ceti istruiti, generalmente benestanti e urbanizzati e il resto della popolazione. Contemplerebbe anche aspetti decisamente classisti, ad esempio la difesa della "gestazione per altri" -di fatto prerogativa di ricchi acquirenti di neonati- colpevoli anche di aver levato gravi conflitti nello stesso campo progressista. La focalizzazione sui diritti delle persone trans avebbe spaccato e indebolito il movimento femminista. Centrando la propria attenzione sui diritti delle minoranze sessuali e sui migranti anziché sugli immigrati, la sinistra avrebbe finito per ignorare quasi del tutto il punto di vista dell suo elettorato storico, che del follemente corretto non condivide e non capisce le ragioni.
Luca Ricolfi - Il follemente corretto. L'inclusione che esclude e l'ascesa della nuova élite. Milano, La Nave di Teseo 2024. 336pp.
Luca Ricolfi - Il follemente corretto. L'inclusione che esclude e l'ascesa della nuova élite
- Visite: 111
